Giacomo Leopardi nasce a Recanati il 29 giugno del 1798 da Adelaide Antici e dal conte Monaldo Leopardi ,primo di 10 figli ,di cui solo lui, ,Paolina, Carlo Pierfrancesco e Luigi restano in vita.
Giacomo stesso ha una salute assai cagionevole:soffre di artrite reumatoide, scoliosi, colite ulcerosa asma e non solo, ma anche i fratelli non sono di buona salute, forse per la consanguineità dei genitori,che erano cugini tra loro.
Giacomo, che è considerato uno dei più grandi poeti di tutto l’800 nel panorama europeo e non solo, è altresì scrittore di commedie , filologo ,matematico,studioso del cosmo e delle lingue e filosofo ,in quanto elabora una sua teoria del piacere e del dolore che è quanto mai degna di attenzione e condivisione ancora oggi. Classicista, materialista, romantico sono altri aggettivi che gli si possono attribuire in merito al suo modo di concepire l’arte e la sua visione .
E’conosciuto,comunemente, come il poeta del pessimismo ma questa sua visione della vita e del mondo,espressa in poesia e nello “Zibaldone “, sorta di libro di appunti e considerazioni, trova appiglio in un sistema di pensiero profondamente logico.
Indubbiamente la sua esperienza di vita, a partire dai rapporti con la famiglia,dalla quale ,fatta eccezione per Carlo e Paolina, non si sentiva abbastanza amato e caratterizzata da una salute malferma alla quale si aggiunse un disturbo alla vista,non gli ha giovato.
Il suo carattere ombroso e schivo,dovuto forse anche ad una superiorità intellettiva e ad una cultura non riscontrabile facilmente nei suoi coetanei,unitamente al suo aspetto fisico non piacente,non gli hanno reso facile i rapporti e la frequentazione degli altri e tantomeno con le donne.
Si è più volte innamorato ma senza alcuna speranza di successo, di donne conosciute nel suo ambiente :esperienze che hanno accentuato il suo pessimismo e il suo rapporto conflittuale con la vita. Leopardi infatti ci stupisce per quanto sia delicato e attento a cogliere i vari aspetti della natura,specie nelle sfumature di passaggio da una stagione ad un’altra o da un particolare momento della giornata , per poi arrivare a deprecare la delusione e esprimere la negatività di quella natura,che alletta gli uomini con le sue lusinghe per poi presentare il suo conto nelle malattie e nella morte stessa.
Parlare di Leopardi significa aprire uno scenario senza possibilità di chiusura , tanti sono gli aspetti che egli osserva nella vita di ogni giorno come ad esempio il fatto che il tedio che è un quid più forte della noia,sia un male oscuro che colpisce soprattutto chi ha troppo tempo senza occupazione alcuna o la tristezza,che subentra immediatamente dopo aver provato un qualsiasi illusione di gioia.Eppure …guai a vivere senza sogni e illusioni che sono quello per cui si continua a vivere e la scienza,spiegandoci ambiti prima riservati alla fantasia o alla supposizione, ci fa essere sempre più consapevoli, ma per questo ,infelici; oppure il ricordo…chi non sa che il ricordo addolcisce il vero e lo rende più accettabile ?
Come abbiamo detto, parlare di Leopardi significa seguire un percorso che si snoda in cento e più sfaccettature :valga per ricordarcelo leggere un paio delle sue meravigliose composizioni che tutti abbiamo studiato e che continueranno ad essere oggetto di riflessione e meraviglia.
Nella prima c’è lo sconsolato accorgersi di come lui sia un “diverso” e di quanto poi si pentirà di non essere riuscito ad essere come i suoi coetanei ,a differenza del passero che segue un comportamento consono alla sua natura, nella seconda c’è un pessimismo fortissimo che induce Leopardi,dopo al morte di Silvia(forse Teresa,figlia del fattore di casa Leopardi) a considerare la natura matrigna che ci illude per poi toglierci ogni speranza e la vita stessa.
Il passero solitario
D’in su la vetta della torre antica,
Passero solitario, alla campagna
Cantando vai finché non more il giorno;
Ed erra l’armonia per questa valle.
Primavera dintorno
Brilla nell’aria, e per li campi esulta,
Sì ch’a mirarla intenerisce il core.
Odi greggi belar, muggire armenti;
Gli altri augelli contenti, a gara insieme
Per lo libero ciel fan mille giri,
Pur festeggiando il lor tempo migliore:
Tu pensoso in disparte il tutto miri;
Non compagni, non voli,
Non ti cal d’allegria, schivi gli spassi;
Canti, e così trapassi
Dell’anno e di tua vita il più bel fiore.
Oimè, quanto somiglia
Al tuo costume il mio! Sollazzo e riso,
Della novella età dolce famiglia,
E te german di giovinezza, amore,
Sospiro acerbo de’ provetti giorni
Non curo, io non so come; anzi da loro
Quasi fuggo lontano;
Quasi romito, e strano
Al mio loco natio,
Passo del viver mio la primavera.
Questo giorno ch’omai cede alla sera,
Festeggiar si costuma al nostro borgo.
Odi per lo sereno un suon di squilla,
Odi spesso un tonar di ferree canne,
Che rimbomba lontan di villa in villa.
Tutta vestita a festa
La gioventù del loco
Lascia le case, e per le vie si spande;
E mira ed è mirata, e in cor s’allegra.
Io solitario in questa
Rimota parte alla campagna uscendo,
Ogni diletto e gioco
Indugio in altro tempo: e intanto il guardo
Steso nell’aria aprica
Mi fere il Sol che tra lontani monti,
Dopo il giorno sereno,
Cadendo si dilegua, e par che dica
Che la beata gioventù vien meno.
Tu, solingo augellin, venuto a sera
Del viver che daranno a te le stelle,
Certo del tuo costume
Non ti dorrai; che di natura è frutto
Ogi vostra vaghezza.
A me, se di vecchiezza
La detestata soglia
Evitar non impetro,
Quando muti questi occhi all’altrui core,
E lor fia voto il mondo, e il dì futuro
Del dì presente più noioso e tetro,
Che parrà di tal voglia?
Che di quest’anni miei? che di me stesso?
Ahi pentirommi, e spesso,
Ma sconsolato, volgerommi indietro.
A Silvia
Silvia, rimembri ancora
Quel tempo della tua vita mortale,
Quando beltà splendea
Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,
E tu, lieta e pensosa, il limitare
Di gioventù salivi?
Sonavan le quiete
Stanze, e le vie dintorno,
Al tuo perpetuo canto,
Allor che all’opre femminili intenta
Sedevi, assai contenta
Di quel vago avvenir che in mente avevi.
Era il maggio odoroso: e tu solevi
Così menare il giorno.
Io gli studi leggiadri
Talor lasciando e le sudate carte,
Ove il tempo mio primo
E di me si spendea la miglior parte,
D’in su i veroni del paterno ostello
Porgea gli orecchi al suon della tua voce,
Ed alla man veloce
Che percorrea la faticosa tela.
Mirava il ciel sereno,
Le vie dorate e gli orti,
E quinci il mar da lungi, e quindi il monte.
Lingua mortal non dice
Quel ch’io sentiva in seno.
Che pensieri soavi,
Che speranze, che cori, o Silvia mia!
Quale allor ci apparia
La vita umana e il fato!
Quando sovviemmi di cotanta speme,
Un affetto mi preme
Acerbo e sconsolato,
E tornami a doler di mia sventura.
O natura, o natura,
Perchè non rendi poi
Quel che prometti allor? perchè di tanto
Inganni i figli tuoi?
Tu pria che l’erbe inaridisse il verno,
Da chiuso morbo combattuta e vinta,
Perivi, o tenerella. E non vedevi
Il fior degli anni tuoi;
Non ti molceva il core
La dolce lode or delle negre chiome,
Or degli sguardi innamorati e schivi;
Nè teco le compagne ai dì festivi
Ragionavan d’amore.
Anche peria fra poco
La speranza mia dolce: agli anni miei
Anche negaro i fati
La giovanezza. Ahi come,
Come passata sei,
Cara compagna dell’età mia nova,
Mia lacrimata speme!
Questo è quel mondo? questi
I diletti, l’amor, l’opre, gli eventi
Onde cotanto ragionammo insieme?
Questa la sorte dell’umane genti?
All’apparir del vero
Tu, misera, cadesti: e con la mano
La fredda morte ed una tomba ignuda
Mostravi di lontano.

































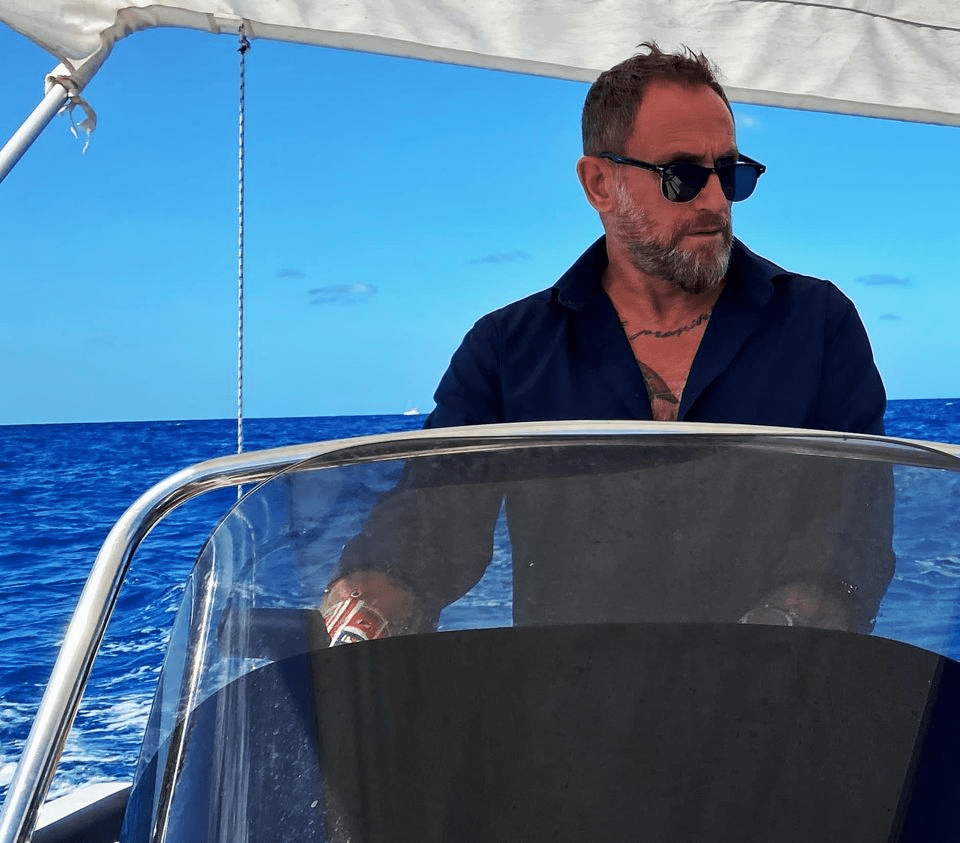
















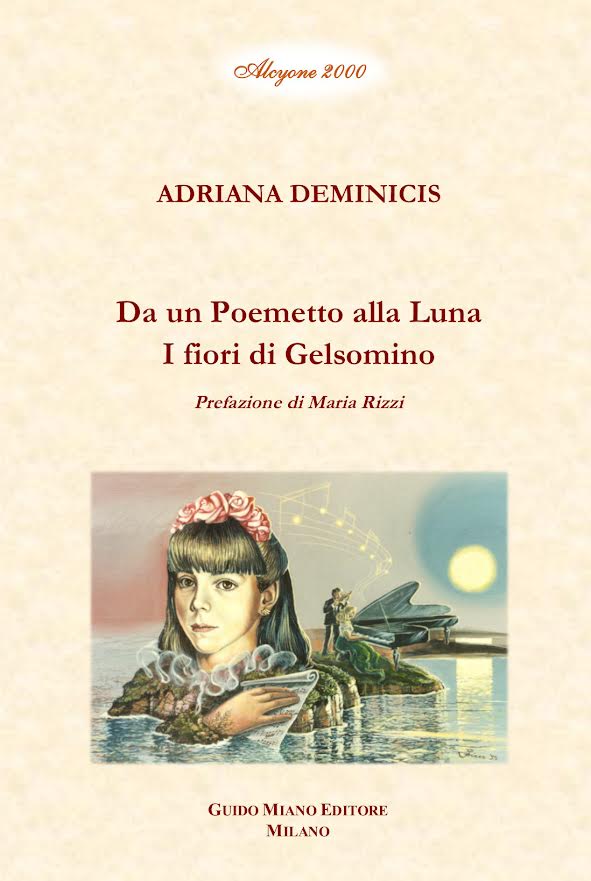












 «Il dono della poesia è il più bello, il più divino che sia concesso all’uomo. E certo serve a lenire le emozioni, quando la loro forza si fa pericolosa. Perciò, credo, non si dovrebbero mai scrivere versi solo per esibire acume o dottrina. A chi può importare di quel tipo di poesia? Chi se ne cura delle frasi dette, delle parole ben scelte? Non vale di più il sentimento genuino, forse espresso con semplicità, financo rozzamente?» leggendo “Shirley” di Charlotte Brontë. Un libro che mi ha catturato, mi ha fatto entrare in un mondo impalpabile in cui è l’anima dei protagonisti a materializzarsi nelle frasi e nei capitoli che scorrono con elegante fluidità. È straordinaria la scrittura al femminile in quest’epoca contraddittoria quale è quella rappresentata dal periodo vittoriano, in cui sono emerse notevoli scrittrici che hanno avuto l’ardire di rappresentare la realtà a loro contemporanea nonostante la palese difficoltà di esternare sentimenti che altresì venivano intenzionalmente celati all’universo femminile. Esplicativa la considerazione che Mario Praz fa di Charlotte Brontë, nel definirla «Una figura energica di donna». Si ha la possibilità di cogliere una prospettiva moderna dei modelli femminili dell’età vittoriana che si incarnano nelle scrittrici che hanno illuminato con il loro talento un periodo particolarmente complesso e articolato. Il secolo XIX ha visto risplendere la dote narrativa di Jane Austen, George Eliot, Elizabeth Gaskell e le sorelle Brontë, pur con le difficoltà connesse con le rilevazioni di genere, tanto da costringere le scrittrici ad avvalersi di uno pseudonimo maschile , come avveniva tra l’altro anche in ambito artistico e musicale. Le fonti riportano la descrizione dei primi incontri col pubblico da parte di Charlotte e delle sue sorelle che erano conosciute con pseudonimi maschili: Currer Bell per Charlotte, Ellis e Acton Bell rispettivamente per Emily e Anne. La storia delle sorelle Bronte ha quasi il sapore della leggenda e tanto si conforma alla natura selvaggia e alle asperità dello Yorkshire, la contea in cui crebbero insieme al padre dopo la prematura scomparsa della madre, da sembrare essa stessa uno dei romanzi scritti dalle Brontë in un’atmosfera di cupo realismo e inquietanti pulsioni, mista a una innata curiosità intellettuale e alla irrefrenabile volontà di sopravvivere alle ferree imposizioni paterne. Charlotte Brontë, autrice di “Jane Eyre”, ha dato vita a una rappresentazione efficace non solo della società vittoriana ma dell’intera epoca narrando una storia d’amore inaccettabile dal punto di vista della morale corrente ma carica di una forza appassionata e combattiva, che riesce a dimostrare la capacità di lottare e di credere nei sentimenti fino in fondo. Il romanzo di Charlotte che, tuttavia, prediligo, è senza dubbio “Shirley”, scritto nel 1849, dove a parer mio viene presentato un contesto sociale più definito anche nelle vicende che si articolano tra i protagonisti, delineati con perizia e raffinata cura dei dettagli psicologici. Si percepisce la sicurezza che deriva dal benessere economico della ricca e tenace proprietaria terriera Shirley, l’umile e riluttante compostezza dell’orfana priva di mezzi Caroline e la sicumera di Robert Moore, industriale caparbio e apparentemente invincibile: uomini e donne, icone di un processo di trasformazione che la società sta subendo in ordine alle contraddizioni insite nel periodo di industrializzazione all’interno della società inglese. Un altro aspetto che emerge è quello del matrimonio e del ruolo della donna: in particolare, attraverso i pensieri di Caroline affiora l’incertezza di una giovane che, impossibilitata a sposarsi, non saprebbe che fare della sua vita; ci si aspetta che ricami e passeggi per il resto dei suoi giorni ma ciò è mortificante. D’altra parte, sposarsi significa spesso sottomettersi al marito, occupando una posizione appartata e altrettanto insoddisfacente. “E chi si preoccupa dell’immaginazione? Chi non la giudica piuttosto pericolosa, un attributo insensato…affine alla debolezza e forse anche partecipe della pazzia…non una qualità ma piuttosto un difetto della mente? Probabilmente tutti la giudicano così, tranne quelli che la posseggono, o che si illudono di averne”.
«Il dono della poesia è il più bello, il più divino che sia concesso all’uomo. E certo serve a lenire le emozioni, quando la loro forza si fa pericolosa. Perciò, credo, non si dovrebbero mai scrivere versi solo per esibire acume o dottrina. A chi può importare di quel tipo di poesia? Chi se ne cura delle frasi dette, delle parole ben scelte? Non vale di più il sentimento genuino, forse espresso con semplicità, financo rozzamente?» leggendo “Shirley” di Charlotte Brontë. Un libro che mi ha catturato, mi ha fatto entrare in un mondo impalpabile in cui è l’anima dei protagonisti a materializzarsi nelle frasi e nei capitoli che scorrono con elegante fluidità. È straordinaria la scrittura al femminile in quest’epoca contraddittoria quale è quella rappresentata dal periodo vittoriano, in cui sono emerse notevoli scrittrici che hanno avuto l’ardire di rappresentare la realtà a loro contemporanea nonostante la palese difficoltà di esternare sentimenti che altresì venivano intenzionalmente celati all’universo femminile. Esplicativa la considerazione che Mario Praz fa di Charlotte Brontë, nel definirla «Una figura energica di donna». Si ha la possibilità di cogliere una prospettiva moderna dei modelli femminili dell’età vittoriana che si incarnano nelle scrittrici che hanno illuminato con il loro talento un periodo particolarmente complesso e articolato. Il secolo XIX ha visto risplendere la dote narrativa di Jane Austen, George Eliot, Elizabeth Gaskell e le sorelle Brontë, pur con le difficoltà connesse con le rilevazioni di genere, tanto da costringere le scrittrici ad avvalersi di uno pseudonimo maschile , come avveniva tra l’altro anche in ambito artistico e musicale. Le fonti riportano la descrizione dei primi incontri col pubblico da parte di Charlotte e delle sue sorelle che erano conosciute con pseudonimi maschili: Currer Bell per Charlotte, Ellis e Acton Bell rispettivamente per Emily e Anne. La storia delle sorelle Bronte ha quasi il sapore della leggenda e tanto si conforma alla natura selvaggia e alle asperità dello Yorkshire, la contea in cui crebbero insieme al padre dopo la prematura scomparsa della madre, da sembrare essa stessa uno dei romanzi scritti dalle Brontë in un’atmosfera di cupo realismo e inquietanti pulsioni, mista a una innata curiosità intellettuale e alla irrefrenabile volontà di sopravvivere alle ferree imposizioni paterne. Charlotte Brontë, autrice di “Jane Eyre”, ha dato vita a una rappresentazione efficace non solo della società vittoriana ma dell’intera epoca narrando una storia d’amore inaccettabile dal punto di vista della morale corrente ma carica di una forza appassionata e combattiva, che riesce a dimostrare la capacità di lottare e di credere nei sentimenti fino in fondo. Il romanzo di Charlotte che, tuttavia, prediligo, è senza dubbio “Shirley”, scritto nel 1849, dove a parer mio viene presentato un contesto sociale più definito anche nelle vicende che si articolano tra i protagonisti, delineati con perizia e raffinata cura dei dettagli psicologici. Si percepisce la sicurezza che deriva dal benessere economico della ricca e tenace proprietaria terriera Shirley, l’umile e riluttante compostezza dell’orfana priva di mezzi Caroline e la sicumera di Robert Moore, industriale caparbio e apparentemente invincibile: uomini e donne, icone di un processo di trasformazione che la società sta subendo in ordine alle contraddizioni insite nel periodo di industrializzazione all’interno della società inglese. Un altro aspetto che emerge è quello del matrimonio e del ruolo della donna: in particolare, attraverso i pensieri di Caroline affiora l’incertezza di una giovane che, impossibilitata a sposarsi, non saprebbe che fare della sua vita; ci si aspetta che ricami e passeggi per il resto dei suoi giorni ma ciò è mortificante. D’altra parte, sposarsi significa spesso sottomettersi al marito, occupando una posizione appartata e altrettanto insoddisfacente. “E chi si preoccupa dell’immaginazione? Chi non la giudica piuttosto pericolosa, un attributo insensato…affine alla debolezza e forse anche partecipe della pazzia…non una qualità ma piuttosto un difetto della mente? Probabilmente tutti la giudicano così, tranne quelli che la posseggono, o che si illudono di averne”.